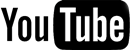Le trasformazioni di una città in continuo movimento. Testo di Corrado Augias
Che cosa ritraggono queste fotografie? Intanto la superficie delle cose con una ricchezza di dettagli che appare ora commovente ora spietata. I fotogrammi nulla omettono di ciò che è stata la realtà di persone e luoghi. La certificazione del passato ci arriva dunque intatta, semmai arricchita dalla patina degli anni. L’aria della città era più pulita, la luce più trasparente, il traffico (talvolta, non sempre) meno congestionato, la forza “monumentale” dei luoghi storici più intensa anche se la loro conservazione era quasi sempre deplorevole. Le abitazioni però erano più misere, l’igiene personale più incerta, gli abiti più trasandati, strumenti e mezzi di lavoro più arretrati, non di rado rudimentali osservati con sguardo contemporaneo. Per di più il contrasto tra i luoghi classici di Roma e quelli dove uomini e donne vivevano, spesso drammatico.
Credo di poter dire che il senso di questa esposizione, nella parte che riguarda le “trasformazioni urbanistiche”, sia di sottolineare il cambiamento, ma anche di collocare il passato nella prospettiva che gli compete, fuori da ogni indebita nostalgia, da quel velo di compiaciuto rimpianto che alle volte ci afferra quando esaminiamo i documenti sulla vita e i luoghi di chi ci ha preceduto. Come scrive Roland Barthes: “La fotografia non dice (per forza) ciò che non è più, ma solo e sicuramente ciò che è stato…l’essenza della fotografia è di ratificare ciò che essa ritrae” (Da “La camera chiara”).
Nella seconda metà dell’Ottocento, e in modo più accentuato dopo il 1870, Roma tenta di assumere l’aspetto di ogni altra “moderna” capitale europea. I pastori provenienti dal contado continuano ad attraversarla con le loro greggi e le mandrie, ancora negli anni Cinquanta sfiorano le nuove periferie. Acquisiscono però un loro carattere i luoghi dedicati al passeggio, agli acquisti, agli incontri di un’embrionale borghesia e dei numerosi visitatori stranieri. Piazza di Spagna, il Corso, piazza San Pietro sono alcune delle mete preferite che vanno quindi arricchendosi di negozi e di un arredo urbano all’altezza delle nuove esigenze.
Si ha un’idea di che cosa è stata Roma negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento? Nei primi frenetici decenni che seguirono il completamento dell’unità nazionale? Le trasformazioni che l’arrivo degli ‘italiani’ e poi la destinazione della città a capitale hanno comportato furono enormi. La piccola ‘Breccia’ aperta dalle cannonate di Lamarmora, cento metri a ovest di Porta Pia, in sé ebbe un significato più simbolico che militare. Ma d’improvviso fu come se, grazie a quella modesta apertura, nell’antica città fosse entrata aria nuova. Roma aveva rotto il suo isolamento di secoli e nel volgere di pochi anni la sua vita cambiò in modo che alcuni giudicarono traumatico.
Queste foto documentano solo le trasformazioni urbanistiche; in realtà cambiò tutto. La popolazione di colpo comincia ad aumentare, il tessuto urbano s’espande ricoprendo di case e di strade i terreni che fino a poco tempo prima erano stati vigna, boscaglia e pascolo. Perfino i venerandi monumenti della Roma classica devono essere ‘aggiustati’ o isolati perché la loro presenza non intralci troppo il movimento della Roma moderna. Cresce il reddito e quindi cambiano i costumi. Cambiano la lingua e i divertimenti, gli orari del lavoro e dell’ozio, perfino i delitti. Nei primi due anni dopo Porta Pia, la popolazione aumenta del 10 per cento. Negli anni successivi l’incremento seguirà una curva ascendente di andamento costante. All’avvento di Roma capitale, subito dopo il 1870, la città aveva una popolazione di soli 270 mila abitanti; trent’anni dopo, all’aprirsi del nuovo secolo, erano già saliti a 460 mila. A cavallo tra i due secoli Roma si presenta come una città di più che modeste dimensioni al centro di una campagna spopolata e spesso desertica caratterizzata, a nord, da balze tufacee frammiste a dirupi, forre, boscaglia. A
sud, da un paesaggio dominato dai ruderi imponenti degli acquedotti, la cui progressiva rovina aveva provocato il sorgere di numerosi acquitrini e terreni paludosi. In queste lande vive una popolazione misera, spesso afflitta da malattie endemiche, dedita alla pastorizia e alla fabbricazione di formaggi quando non ad un’occasionale banditismo. Le loro abitazioni erano abituri e capanne non di rado poggiate ai muri residui di edifici classici. La stessa via Appia (regina viarum) appariva in stato di totale abbandono, mentre i due fiumi, Tevere e Aniene, correvano liberamente tra argini naturali, causa non ultima di guasti ricorrenti. In 30 anni (censimento del 1901) i cittadini romani erano aumentati del 150 per cento arrivando a sfiorare il mezzo milione di abitanti. Meno della metà (46 per cento) sono nati a Roma. La capitale papalina era stata una città pigra, con un’amministrazione blanda e noncurante, la città viva, quei meno di 300 mila abitanti, era per lo più concentrata nell’ansa del Tevere. Dopo il 1870 arrivano funzionari e impiegati, commercianti e professionisti, politici e giornalisti, un buon numero di speculatori che hanno fiutato gli affari che si possono realizzare utilizzando, per lo più, denaro pubblico. La stessa plebe cambia, o sta per cambiare; scrive un cronista: «La plebe d’oggi non è quella di cent’anni fa e neppure quella di mezzo secolo fa. Il tempo cambia tutto e l’onda incessante della civiltà penetra dappertutto e neppure il prete poté arrestarla alle porte di Roma…». Ma il cambiamento massimo è che, in ritardo di un buon secolo sulle altre capitali, anche Roma comincia ad avere una borghesia. Sotto il dominio papale la popolazione cittadina era fatta di nobili, preti e plebei. Con l’arrivo dei piemontesi e d’una adeguata amministrazione dello Stato, si forma quel ceto intermedio che diventa a sua volta protagonista d’altri cambiamenti che vanno dalla politica all’editoria e allo spettacolo.
Naturalmente anche la nascita del nuovo ceto e della città nuova ebbe un prezzo. Il più caro e vistoso, proprio per la sua spettacolarità, fu la criminale distruzione di villa Boncompagni Ludovisi. Bisogna fare un grande sforzo di fantasia per immaginare oggi l’area di via Veneto e delle strade adiacenti da porta Pinciana fin oltre il palazzo Margherita (attuale sede dell’Ambasciata degli Stati Uniti) interamente ricoperto di un parco secolare ornato di statue e tempietti di tale maestà e bellezza da far esclamare a Henry James: «Nulla v’era a Roma di più affascinante e grandioso».
L’area venne fatta a pezzi e venduta dai proprietari. Un pessimo esempio che sarebbe sicuramente stato imitato dai principi Borghese se alcuni vincoli provvidenziali, anche se tardivi, sulla loro villa, non l’avessero impedito. Nel 1881 mette piede a Roma, tra i tanti, un giovane diciottenne di sicuro talento e di fortissima ambizione. Di suo si sarebbe chiamato Rapagnetta se suo padre non fosse stato adottato da un parente assumendone in via definitiva il cognome: D’Annunzio. Ricordando il momento del suo arrivo, il giovane Gabriele così descrive Roma in quegli anni febbrili: «Era il tempo in cui più torbida ferveva l’operosità dei distruttori e dei costruttori. Insieme con nuvoli di polvere si propagava una specie di follia edificatoria, con un turbine improvviso…Fu allora, dappertutto, come un contagio di volgarità. Nel contrasto incessante degli affari, nella furia quasi feroce degli appetiti e delle passioni, nell’esercizio disordinato ed esclusivo delle attività utili, ogni senso estetico, ogni rispetto del passato fu deposto».
Quella Roma la conosciamo sotto il nome di ‘Terza Roma’, terza dopo la Roma dei Cesari e dei papi. Fecero seguito una prima fase d’insediamento fino alla morte di Vittorio Emanuele II (1878), un periodo che corrisponde al regno di Umberto I (1878-1900) e un periodo che prende nome dalla poderosa personalità di Giovanni Giolitti (1900-1920 ca.). È in questi anni che la città comincia ad affrontare profonde trasformazioni: nascono nuovi quartieri, centinaia di nuovi edifici, tra i quali quelli dei ministeri e degli alloggi per i funzionari dello Stato. Sorgono le nuove periferie nel mezzo della campagna, su terreni agricoli dove per secoli avevano pascolato le greggi, alcune sono dignitosissime, altre destinate fin dalla nascita ad un rapido degrado. Con gli sventramenti del centro storico ideati dal fascismo, cominceranno poi a nascere negli anni Trenta le borgate dove i residenti verranno trasferiti. Ma per quanto riguarda la parte centrale e funzionale della città, due delle più importanti realizzazioni, inaugurate entrambe nel 1911, anno celebrativo del cinquantenario del Regno, furono il nuovo Palazzo di Giustizia sul Lungotevere e il monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) addossato, con una decisione subito molto criticata, al colle capitolino.
Gli ampliamenti dell’epoca umbertina e giolittiana continueranno durante il fascismo con un intento più dichiaratamente politico e spettacolare. Sulla scorta del resto di quanto andava facendo Adolf Hitler a Berlino. Mussolini capo del governo dà mano alla costruzione dell’E42 (oggi: Eur) nella deserta campagna tra Roma e il mare, al grande complesso del Foro Mussolini (oggi: Italico) nella zona settentrionale vicina a ponte Milvio. La febbre edilizia continuerà anche negli anni Cinquanta con nuove costruzioni in genere modeste, a parte alcune ben individuate eccezioni, e con la nascita di quartieri nuovi nei quali la spinta speculativa diventa evidente nell’addensarsi soffocante della abitazioni, nell’assenza di ogni spazio pubblico, ricreativo, associativo. Sono i famigerati quartieri-dormitorio che si estenderanno a macchia d’olio invadendo zone sempre più estese di campagna.
Il senso complessivo della mostra può forse essere riassunto in questi termini: mostrare il cambiamento rispetto all’oggi e collocare il passato nella prospettiva che gli compete. Dare a noi contemporanei alcune chiavi che permettano di vedere meglio chi erano i romani e da dove viene la città che è sotto i nostri occhi. Sommare la razionalità della documentazione e la forza evocatrice che la freddezza delle immagini sa dare. Attraverso gli anni Roma è certamente molto cambiata avendo del tutto perso, per esempio, le sue connotazioni agresti. Resta tuttavia la sua nota di fondo data dall’evidente convivenza di antico e moderno, dalla sorprendente, toccante, contiguità e dal sommarsi, strato su strato, di molti e differenti periodi della storia che qui hanno avuto origine o che Roma hanno comunque attraversato. Era questa caratteristica a farne una città unica nel mondo, tale rimane.
Corrado Augias