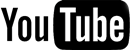Vita sociale a Roma. Testo di Elisabetta Rasy
Dal basso verso l’alto, due operai guardano l’obiettivo concedendosi un istante di sosta. Altri non si sono nemmeno accorti che uno sconosciuto li sta fotografando e continuano il loro lavoro, o forse non hanno voglia di perdere tempo. Sono i soldati di una nuova guerra, la guerra della ricostruzione, per la quale non c’è tempo da perdere. È l’estate del 1947, la città, con i nervi scossi, si sta riprendendo dai disastri bellici. Ma è una città particolare. Nel terreno dove stanno lavorando ci sono calcinacci, mattoni, pezzi di muro al suolo; più in là però si intravede la sagoma imponente di un edificio antico, l’Acquedotto Alessandrino. Non si tratterà solo di riedificare quello che la guerra ha distrutto, ma di rianimare e reinvestire di senso la misteriosa stratificazione di epoche, monumenti e civiltà che costituisce la fisionomia unica di Roma, perché possa davvero diventare, voltando pagina, la capitale della nuova repubblica italiana. Delle foto che riguardano la vita sociale a Roma nel Novecento tratte dall’archivio fotografico dell’Ufficio Stampa capitolino, quella degli operai all’Acquedotto Alessandrino, con il loro sguardo mite e interrogativo rivolto all’obiettivo e il corpo visibilmente segnato dalla fatica e dal sole, è stata la prima ad attirare la mia attenzione perché indica con semplice immediatezza la chiave del fascino di queste immagini che raccontano la città insieme ai suoi abitanti. Ci fa capire che queste fotografie non illustrano soltanto lo spazio abitato della città, ma colgono il rumore del tempo e insieme il paesaggio interiore della storia, che è poi, aldilà degli avvenimenti e delle date, la vita quotidiana degli esseri umani. In questa foto tutto è eloquente: la luce accecante, il viso severo dell’operaio in primo piano, l’ombra che scorgiamo al margine sinistro, china e con uno strumento di lavoro in mano, simile all’ombra di una statua antica. In quel lontano luglio non ero ancora nata (mancava poco, però), ma quegli operai sullo sfondo dell’antico monumento è come se li avessi visti e anche osservati con i miei occhi perché certe foto ci propongono relazioni che non sapevamo di avere, ci attraggono nel legame misterioso di un lontano rapporto umano a dispetto degli anni e dei decenni che sono passati.
Così funzionano queste immagini che abbiamo davanti allo sguardo, estranee e familiari insieme, cioè perturbanti, testimoni di una storia che ci riguarda anche se non c’eravamo. Osservandole come un campo di forze si nota in esse un doppio movimento, una tensione contrastante: da un lato c’è l’evento, la situazione precisa che il reporter ha voluto rappresentare o documentare con il suo scatto, ma dall’altro, dentro la scena inquadrata, c’è l’imprevedibile, il non programmabile della vita che racconta la sua storia. È quel particolare – punctum lo ha definito Roland Barthes - che attrae l’attenzione, quel frammento di immagine che ci punge.
Un’altra foto di operai è datata 1954: stesse canottiere bianche, in mezzo alle quali troneggia il cappello nero dell’imprenditore – il mio polo d’attrazione qui è il contrasto tra cappello e canottiere, come fossero attori della difficile scena sociale, tra vecchie ingiustizie e un nuovo desiderio di giustizia, che era l’Italia di quegli anni. Questi operai devono fare un lavoro diverso dai colleghi che rimettono in piedi la città. Per renderla adeguata ai tempi, loro devono invece demolirne un pezzetto: costruiranno il sottopassaggio di Largo Tritone. Comincia, tra difficoltà e contrasti e decisioni a volte buone a volte cattive, l’epopea postbellica dei lavori urbani, perché “la città che sale” lo fa ormai molto più velocemente che in quel 1910 in cui Umberto Boccioni aveva così intitolato un suo paesaggio romano. Dopo la guerra Roma è capolinea di una nuova ondata migratoria, dalle campagne laziali ma anche dal Centro, dal Sud e in misura minore persino dal
Nord, trasformandosi in un coagulo delle diverse identità italiane. Nel censimento del 1961 la capitale conta 2.188.160 abitanti, più del doppio di trent’anni prima (ma nel 1881 erano 300.467).
Nell’estensione urbana in movimento i romani devono affrontare un nuovo problema: la mobilità. Nel cuore della città cresce la vegetazione ingombrante delle automobili, non senza perplessità, come indica lo sguardo sconsolato su auto e pedoni del vigile in via dei Fori Imperiali. Altrove, però, i suoi colleghi svolgono funzioni più drammatiche. La sagoma di un vigile, divisa bianca e bicicletta, si staglia dietro quella di un uomo malvestito e malnutrito con un bambino in braccio: è una foto del ’54 che documenta lo sgombero dei baraccati a Tor Marancia. Molti nuovi romani del dopoguerra vivono in accampamenti, baraccamenti, grotte. All’orizzonte si profilano le grandi lotte per la casa degli anni Sessanta e Settanta. Qui, in questa scena, tutti sembrano ammutoliti, la foto sprigiona silenzio, gli sguardi degli uomini e delle donne non sono rivolti all’obiettivo ma verso qualcosa che non vediamo, qualcosa che forse ha a vedere con la paura forse con la speranza.
Le fotografie dell’archivio dell’Ufficio Stampa del Comune ci ricordano che la città non è solo un insieme di strade e edifici e funzioni, ma una societas di sentimenti, e che a tenere insieme i cittadini non sono muri e selciati ma legami di familiarità e identificazione profonda con il luogo in cui vivono. Immagini antiche si sovrappongono alle nuove e viceversa. Di quello stesso anno 1954 è la sequenza fotografica della solenne processione in occasione della canonizzazione di Papa Sarto, al soglio con il nome di Pio X: le immagini mostrano con grande forza la potente lentezza di quella secolare tradizione. Devono passare più di vent’anni - sto guardando una foto del ’78 – perché un giovane Papa polacco arrivi eretto su una macchina, con il suo viso aperto di operaio pensatore, a portare il vento veloce del cambiamento a Piazza San Pietro.
L’iconografia urbana ci racconta la lenta avanzata del processo di integrazione tra passato e presente e i suoi passaggi cruciali. Guardiamo una foto del febbraio 1964: forse all’interno della Biblioteca di via del Governo Vecchio non fa tanto caldo, perché la giovane donna che sta trascrivendo i dati dell’utente che chiede in prestito un libro indossa il cappotto. Anche l’utente ha il cappotto: a un primo sguardo sembra un uomo maturo, ma poi osservando meglio si capisce che è un giovanotto che ha cercato di domare in una controllata pettinatura l’irruenza ondosa dei suoi capelli. Ma per accorgersi che è un ragazzo bisogna soffermarsi sull’immagine, perché i ventenni allora erano ancora vestiti da uomini fatti e le ragazze, come la giovane bibliotecaria che trascrive il documento, da signore adulte. (Il libro sul tavolo è Ottavio di Saint Vincent, di Landolfi, una lettura affascinante e impegnativa). Passano solo tre anni e i ragazzi hanno smesso di vestirsi come i loro padri. Siamo alla bellissima sequenza fotografica sul Piper, la discoteca di via Tagliamento che trasformò in città il concetto di sala da ballo. E non sono cambiati solo i vestiti - rigorosamente eclettici e informali o neoromantici - è cambiato soprattutto il ballo, e diversa rispetto al passato è la relazione tra i ballerini. I movimenti sono diventati scoordinati, disarticolati, esorbitanti, e i balli del mattone, in cui le coppie si abbandonano all’abbraccio o si guardano languidamente negli occhi, si alternano a danze in cui tra maschi e femmine ogni legame è sospeso e lo sguardo vaga in direzioni lontane dal partner – quasi una corporea anticipazione di quella ricerca di nuove posizioni maschili e femminili che si sta profilando nella società. Intanto però le donne sono sempre più presenti sulla scena del lavoro: in una foto del ’67 una giovane donna ben pettinata e ben vestita chiude la vetrina del suo negozio; in una del ’63 una figura matronale in camice bianco sta prescrivendo qualcosa alle alunne di una scuola mentre una madre con un piccolo in braccio la guarda - allora quelle dottoresse scolastiche si chiamavano vigilatrici, e facevano un po’ paura ai bambini non tanto per l’attività sanitaria ma perché incarnavano un’autorevolezza femminile alla quale non si era abituati.
Le foto sono divise per sezioni (lavori pubblici, feste, scuola eccetera) ma è spostando lo sguardo da una sezione all’altra che si forma il ritratto umano della città, la fisionomia della vita vissuta nelle fatiche e nelle speranze del giorno dopo giorno, e che si afferra, soprattutto, il ritmo del tempo che scorre e la mutevole direzione della storia che non segue sempre un percorso lineare. Per esempio, nelle foto scattate all’inizio del nuovo millennio, Roma è ringiovanita. Sorridono le autorità, allegre come a una festa di famiglia piuttosto che impettite nella rigidità del cerimoniale come in scatti d’altri tempi, all’inaugurazione dell’Auditorium, il 21 aprile 2002: l’opera di Renzo Piano sarà un nuovo luogo simbolico della città, un tempio laico di musica e arte, ma anche di incontri, di incroci culturali, un punto di raccolta e di ritrovo per i cittadini di Roma e del resto del mondo. Le foto intrecciano un dialogo tra ieri e oggi. I lavori pubblici cambiano aspetto: all’immagine della costruzione dei sottopassaggi per i pedoni risponde quella della restaurata galleria di viale Oxford con la nuova illuminazione, perché la città includa a pieno titolo realtà urbane lontane dal centro storico. Alla foto della demolizione delle baracche risponde la scena dell’abbattimento di un edificio abusivo, perché l’edilizia sia per gli uomini e non gli uomini per l’edilizia. Alla foto imponente della firma dei trattati di Roma, marzo 1957, da cui prenderà l’avvio la Comunità Europea , si affianca quella, scattata in Campidoglio nel settembre 2006, dell’incontro dei rappresentanti delle religioni monoteiste per prefigurare una sempre più urgente comunità del sentire umano. Alla scena affettuosa delle care, un po’ polverose feste di una volta si accosta la sequenza dinamica delle notti bianche, con i tanti i significati che i loro arabeschi ci suggeriscono: sconfiggere insieme – amministrazione e cittadini - i pericoli dell’oscurità; inventare gesti nuovi sullo sfondo di luoghi e monumenti antichi, non più blindati e inaccessibili o puro oggetto di devozione ma proprietà della popolazione; un senso di condivisione, di nuova inclusione, tra centro e periferia, tra mondi distanti e generazioni diverse; ma anche un buon uso della memoria, nella traccia di un antico piacere del divertimento collettivo che il tenace popolo romano ha conservato tra mille affanni, e con il sentimento che il ricordare non è attaccamento al passato, ma rivolgersi a quello che abbiamo vissuto per restituire presenza al presente, dotarlo di anima.
Ho lasciato per concludere le foto che mi hanno emozionato di più, quelle dei bambini. A Roma i bambini non se la sono sempre cavata bene. Bastano pochi dati per rendere la situazione. All’inizio del secolo scorso la mortalità infantile per esempio a Testaccio era del trentatré per cento; solo nel 1906 Maria Montessori riuscì con molta fatica ad aprire a San Lorenzo la prima “Casa dei bambini”, spesso strappandoli alla strada. Per loro adesso le cose sono decisamente cambiate in meglio: nel 2007 i bambini accolti nei nidi sono diventati sedicimila e nuove strutture sono in via di realizzazione – anche se molto resta da fare per la popolazione infantile più precaria, i piccoli degli immigrati. Ma le foto di questa esposizione ci raccontano qualcos’altro sulla vita quotidiana dell’infanzia a Roma. Uno scatto del 1966 inquadra la mensa della scuola Leopardi. E’ un bell’ambiente, luminoso e attrezzato. Ma è difficile decifrare le fisionomie dei ragazzini seduti alle tavolate: nell’immagine domina il bianco dei grembiulini così che l’impressione è quella di una folla anonima in miniatura, come se quei piccoli esseri fossero privi di individualità, in attesa di cittadinanza. Fa un effetto diverso l’immagine scattata a Lunghezza, Ottavo Municipio, nel dicembre 2002: qui i ragazzini, con maestri e genitori, stanno festeggiando l’apertura della scuola materna. Alcuni di loro fanno un girotondo, ma i più stanno solennemente a guardare, dando l’impressione che stiano celebrando la conquista di un diritto e che ne abbiano la consapevolezza, da veri cittadini. Altra inaugurazione, sempre nel 2002, altra occasione. Si tratta dell’apertura del nuovo Centro Commerciale Casilino. Il tradizionale nastro delle inaugurazioni lo sta tagliando un ragazzino, maglietta a righe, sneakers ai piedi, che tiene per mano una bimbetta compresa del suo ruolo. Anche il ragazzino è molto concentrato su quello che sta facendo, è lui in quel momento il primo cittadino della situazione, e non si cura affatto del signore che gli sta accanto, che poi è il sindaco Veltroni. Anzi è il sindaco a mettersi al servizio del ragazzino, tendendogli il nastro. In questa foto il punto d’attrazione, il punctum di Barthes, è la posizione del sindaco, chino verso il piccolo cittadino di modo che le due teste, dell’adulto e del bambino, sono quasi alla stessa altezza, e soprattutto le sue mani, che collaborano all’operazione, che è, vuole essere, un’azione fatta insieme.
Elisabetta Rasy